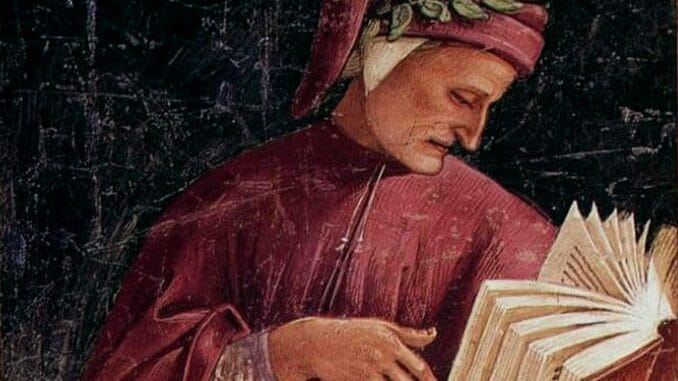
di Fabrizio Pinna – “Ben so, per molti altri molto meglio e più discretamente si saria potuto mostrare; ma chi fa quel che sa, più non gli è richiesto”. Giovanni Boccaccio fu uno dei primi appassionati dantisti e in alcuni codici (il Toledano 104 6, il Riccardiano 1035, il Chigiano L VI 213) che raccoglievano sue trascrizioni di opere di Dante, alle tre cantiche della Divina commedia aveva premesso dei sunti (“Argomenti”) in terza rima, insieme – come ricordava Giorgio Padoan nell’ Enciclopedia Dantesca (Treccani, 1970) – a “una breve rubrica riassuntiva in prosa per ogni canto”.
Nella selva oscura dei nostri pandemonici tempi qualche giorno fa, il 21 marzo, si è celebrata la Giornata mondiale della poesia: ricordando simbolicamente entrambe le ricorrenze, l’omaggio di un grande prosatore a un grande poeta mi sembra un buon modo per celebrare oggi – 25 marzo – il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che quest’anno commemora anche il settecentesimo anniversario della sua morte,
Senza andare troppo avanti o indietro nel tempo, a inizio del secolo scorso Giuseppe Gigli incluse gli “argomenti” nella sua Antologia delle opere minori di Giovanni Boccaccio (Firenze, Sansoni, 1907) e successivamente entrarono nel terzo volume dell’edizione – curata da Domenico Guerri – che raccoglieva tutti gli scritti danteschi di Boccaccio (Il Comento alla Divina Commedia, e gli altri scritti intorno a Dante, Roma-Bari, Laterza, 1918, 3 voll.), e che qui si segue nel riproporre le terze rime.
Boccaccio: Argomenti in terza rima alla “Divina commedia” di Dante Alighieri
ALL’INFERNO
«Nel mezzo del cammin di nostra vita», smarrito in una valle l’autore, e la sua via da tre bestie impedita, Virgilio, dei latin poeti onore, da Beatrice gli apparve mandato liberator del periglioso errore. Dal qual poi che aperto fu mostrato a lui di sua venuta la cagione, e ’l tramortito spirto suscitato, senza più far del suo andar quistione, dietro gli va, ed entra in una porta ampia e spedita a tutte persone. Adunque, entrati nell’aura morta, l’anime triste vider di coloro che senza fama usâr la vita corta; io dico de’ cattivi: eran costoro da moscon punti, e senza alcuna posa correndo givan, con pianto sonoro. Quindi, venuti sopra la limosa riva d’un fiume, vide anime assai, ciascuna di passar volenterosa. A cui Caròn:—Per qui non passerai!— di lontan grida; appresso, un gran baleno gli toglie il viso e l’ascoltar de’ guai. Dal qual tornato in sé, di stupor pieno, di là da l’acqua in più cocente affanno, non per la via che l’anime teniéno, si ritrovò; e quindi avanti vanno, e pargoletti veggon senza luce pianger, per l’altrui colpa, eterno danno. Dietro alle piante poi del savio duce passa con altri quattro in un castello, dove alcun raggio di chiarezza luce. Quivi vede seder sovr’un pratello spiriti d’alta fama, senza pene, fuor che d’alti sospiri, al parer d’ello. Da questo loco discendendo, viene dove Minós esamina gli entranti, fier quanto a tanto officio si conviene. Quivi le strida sente e gli alti pianti di quei che furon peccator carnali, infestati da venti aspri e sonanti, dove Francesca e Polo li lor mali contano. E quindi Cerbero latrante vede sopra a’ gulosi, infra li quali Ciacco conosce; e, procedendo avante, truova Plutone, e’ prodighi e gli avari vede giostrar con misero sembiante. Che sia Fortuna e la cagion de’ vari suoi movimenti Virgilio gli schiude: e, discendendo poi con passi rari, truovan di Stige la nera palude, la qual risurger vede di bollori, da’ sospir mossi d’alme in essa nude, dove gli accidiosi peccatori, e gl’iracundi, gorgogliando in quella, fanno sentir li lor grevi dolori. Sopra una fiamma poi doppia fiammella subito vede, ed una di lontano surgere ancora e rispondere ad ella. Quivi Flegias, adirato, il pantano oltre gli passa, nel qual vede strazio far di Filippo Argenti, e non invano. E appena era di tal mirare sazio, ch’a piè della città di Dite giunti, senza esser lor d’entrarvi dato spazio, si vide, e quindi da disdegno punti per la porta serrata lor nel petto da li spiriti più da Dio disiunti. E mentre quivi stavan con sospetto, le tre Furie infernai sovra le mura Tesifon, vider, Megera ed Aletto. Appresso, acciò che l’orribil figura del Gorgon non vedesse, il buon maestro gli occhi gli chiuse, e fennegli paura. Di scender poi per lo cammin silvestro, per cui la porta subito s’aprio, mostra, e ’l passare a loro in quella, destro. Quivi dolenti strida ed alte udio, che de’ sepolcri uscivano affocati, de’ qual pieno era tutto il loco rio: in quegli essere intese i trascutati eresiarci, e tutti quelli ancora ch ’a Epicuro dietro sono andati. Lì, ragionando, picciola dimora con Farinata e con un altro face, ch’alquanto a l’arca pareva di fora. Disegna poi come lo ’nferno giace, da indi in giù, distinto in tre cerchietti, e poi dimostra con ragion vivace perché dentro alle mura i maladetti spiriti sien di Due, e nel suo cerchio, più che color che ha di sopra detti. Centauri truova poi sovr’al coperchio d’un’altra valle sovra Flegetonte, nel qual chi fe’ al prossimo soverchio bollir vede per tutto; e perché cónte le vie salvagge, a passar la riviera Nesso gli fa della sua groppa ponte. Oltre passati, in una selva fiera di spirti, in bronchi noderosi e torti mutati, entraron per via straniera. Tutti se stessi i miseri avien morti, che li piangean, divenuti bronconi; dove gli fe’ Pier delle Vigne accorti delle dolenti lor condizioni e delle sue; e nella selva stessa, dopo gli uditi miseri sermoni, da nere cagne un’anima rimessa vide sbranare, e seppe a tal martiro dannato chi la sustanzia, commessa all’util suo, biscazza. E quindi giro più giù, dove piovean fiamme di foco, fuor della selva, sovra un sabbion diro; là dove Campaneo, curante poco, vider giacer sotto la pioggia grave con più molti arroganti; e ’n questo loco, seguendo, mostra con rima soave d’una statua, ch’ è di più metalli, l’acqua cadere in quelle valli prave, e quattro fiumi per più intervalli nel mondo occulto fare, infino al punto più basso assai che tutte l’altre valli. Poi ser Brunetto abbrusciato e consunto sotto l’orribil pioggia correr vede, col quale alquanto, parlando, congiunto, di sua futura vita prende fede. Poi, Guido Guerra e Tegghiaio Aldobrandi, Iacopo Rusticucci, infino al piede di lui venuti, a’ lor nuovi dimandi sodisfa presto; e quinci procedette dove anime trovò con tasche grandi sedere a collo, sotto le fiammette, di loro alcuni a l’arme conoscendo stati usurieri, e per tre render sette. Poi, sovra Gerion giù discendendo, in Malebolge vene, ove i baratti in diece vede, senza pro piangendo. De’ quali i primi da dimòn son tratti con grandi scoreggiate per lo fondo, scherniti e lassi, vilmente disfatti; là dove alcun ch’avea veduto al mondo vi riconobbe, ch’era bolognese, Venedico, e ruffiano; a cui secondo Iason venia, che tolse il ricco arnese a’ colchi. E quindi Alesso Interminelli in uno sterco vide assai palese pianger le sue lusinghe; e quindi quelli che sottosopra in terra son commessi per simonia; e li par che favelli con un papa Nicola; ed, oltre ad essi, travolti vede quei che con fatture gabbarono non ch’altrui, ma se istessi. Quindi discendon là ove l’oscure pegole bollon chi baratteria vivendo fece, e di quelle misture, mentre che van con fiera compagnia di diece diavol, parla un che fu tratto da Graffiacan per la cottola via, sé navarrese dicendo e baratto; quinci com’el fuggi delle lor mani racconta chiaro, e de’ diavoli il fatto. Sotto le cappe rance i pianti vani degl’ipocriti poi racconta, e mostra Anna e ’l suo suocer nelli luoghi strani crocifissi giacer. Poi, nella chiostra di Malebolge seguente, brogliare fra’ serpi vede della gente nostra, quivi dannati per lo lor furare: Agnolo e ’l Cianfa ed altri e Vanni Fucci; li quai mirabilmente trasformare, dopo nuovi atti, parlamenti e crucci, e d’uomo in serpe, e poi di serpe in uomo, in guisa tal, che mai vista non fucci, discrive. E poi chi mal consiglio, comoda, come Ulisse, in fiamme acceso andando, vede riprender dattero per pomo. Pria con Ulisse, e poscia ragionando col conte Guido, passa; e, pervenuto su l’altra bolgia, vede gente andando tutta tagliata sovente e minuto, per lo peccato della scisma reo da lor nel mondo falso in suso avuto. Lì Maometto fesso discernéo, e quel Beltram che già tenne Altaforte, e Curio e ’l Mosca, e molti qual potéo. Appresso vide più misera sorte degli alchimisti fracidi e rognosi, u’ seppe da Capocchio l’agra morte, e Mirra e Gianni Schicchi e più lebbrosi vide, ed i falsator per fiera sete ritruopichi fumare stando oziosi: tra’ quali in quella inestricabil rete vide Sinón, ed il maestro Adamo garrir con lui, come legger potete. Quindi, lasciando l’uno e l’altro gramo, dal mezzo in su gli figli della terra uscir d’un pozzo vede, ed al richiamo del gran poeta intramendue gli afferra Anteo, e lor sovr’al freddo Cocito posa, nel quale in quattro parti serra il ghiaccio i traditor: quivi ghermito Sassol de’ Mascheron nella Caina, e ’l Camiscion de’ Pazzi, ebbe sentito. oscia nell’Antenora, ivi vicina, tra gli altri dolorosi vide il Bocca, e di Gian Soldanier l’alma meschina, ed altri molti, ch’ora a dir non tocca, si come l’arcivescovo Ruggieri, ed il conte Ugolino, anima sciocca. Più oltre andando pe’ freddi sentieri, spiriti truova nella Ptolomea giacer riversi ne’ ghiacci severi. Quivi, racconta, l’alma si vedea di Brancadoria e di frate Alberico, che senza pro de’ frutti si dolea. Appresso vede l’Avversario antico nel centro fitto, e Iuda Scariotto, e Cassio e Bruto, di Cesar nemico, nell’infima Iudecca star di sotto. Quindi, pe’ velli del fiero animale discendendo, e salendo, il duca dotto lui di fuor tira da cotanto male per un pertugio, onde le cose belle prima rivide, e per cotali scale usciron quindi «a riveder le stelle».
AL PURGATORIO
«Per correr miglior acqua alza le vele» qui lo autore, e, seguendo Virgilio, pe’ dolci pomi sale e lascia il fiele. Catón primier, fuor dell’eterno esilio, truovano e seco parlan, procedendo; poi dánno effetto al suo santo consilio. Su la marina vede, discendendo nell’aurora, più anime sante, e ’l suo Casella, al cui canto attendendo, mentre l’anime nuove tutte quante givan con lor, rimorsi da Catone, fuggendo al monte ne girono avante. Incerti quivi della regione, truovan Manfredi ed altri, che moriro per colpa fuor di nostra comunione col perder tempo, adequare il martiro alla lor colpa; e quindi, ragionando, del solar corso gli solve il desiro l’alto poeta sedendosi, quando Belacqua vider per negghienza starsi; e già levati verso l’alto andando, Bonconte ed altri molti incontro farsi vider, li quali infino all’ultim’ora, uccisi, a Dio penáro a ritornarsi. Quindi Sordel trovar sol far dimora, il qual, poi che l’autor molto ha parlato contro ad Italia, il gran Virgilio onora. Poi mena loro in un vallone ornato d’erbe e di fior, nel qual, cantando, addita, a Virgilio Sordello stando allato, spiriti d’alta fama in questa vita, tra’ quai discesi, il Gallo di Gallura riceve l’autor; quindi, finita del di la luce, vede dell’altura due angeli con due spade affocate discender ad aver di costor cura. Poscia, dormendo, con penne dorate gli par che ’n alto un’aquila nel porti d’infino al foco; quindi, alte levate le luci, spaventato, da’ conforti fatto sicur di Virgilio, Lucia gli mostra quivi loro avere scorti. Del purgatorio gli addita la via, dove venuti, qual fosse disegna la porta, e’ gradi onde a quel si salía, chi fosse il portinaio, che veste tegna, e quai fosser le chiavi, e che scrivesse nella sua fronte, e che far si convegna a chi passa là dentro pone expresse. E quindi come en la prima cornice dichiara con fatica si giugnesse; ed intagliate in alta parte dice di quella istorie d’umiltà verace: poi spirti carchi dall’una pendice vede venir cantando, ed orar pace per sé e per altrui, purgando quello che ne’ mortal superbia sozzo face; tra’ quali Umberto ed Odorisi, ad ello appresso, e simil Provinzan Silvani piangendo vide sotto il fascio fello. Oltre passando pe’ sentieri strani, sotto le piante sue effigiati vide gli altieri spiriti mondani. Da uno splendido angiolo invitati più leggier salgono al giron secondo, perché li «P» l’autor trovò scemati. Lì alte voci, mosse dal profondo ardor di carità, udir volanti per l’aere puro del levato mondo; e poi che giunti furon più avanti, videro spirti cigliati sedere, vestiti di ciliccio tutti quanti, perché la invidia lor tolse il vedere: Guido del Duca, Sapia e Rinieri da Calvol truova lì piangere, e vere cose racconta di tutti i sentieri onde Arno cade, e simil di Romagna; quindi altri suon sentiron più severi. Ed oltre su salendo la montagna, da un altro angelo invitati foro, parlando dell’orribile magagna d’invidia, e dell’opposito, fra loro, e, di sé tratto andando, vide cose pacefiche in aspetto; né dimoro fe’ guari in quelle, che ’n caliginose parti del monte entraron, dove l’ira molti piangean con parole pietose. Quivi gli mostra Marco quanto mira nostra potenzia sia, e quanto possa di sua natura, e quanto dal ciel tira. Appresso usciti dall’aria grossa, imaginando vede crudi effetti venuti in molti da ira commossa. Quivi gl’invia un angel; per che, stretti alla grotta amendue, a non salire dalla notte vegnente fur costretti. Posti a sedere incominciaro a dire insieme dell’amor del bene scemo, che ’n quel giron s’empieva con martire, dove, sì come noi veder potemo, distintamente Virgilio ragiona come si scemi in uno ed altro estremo, che sia amor, del quale ogni persona tanto favella, e come nasca in noi. L’abate li di San Zen da Verona con altri assai correndo vede poi e con lui parla, e seguel nell’oscuro tempo, con altri retro a’ passi suoi, come sentendo si rifà maturo d’accidia l’acerbo. Indi ne mostra come, dormendo in sul macigno duro, qual fosse vide la nemica nostra, e come da noi partasi, e, sdormito, come venisse nella quinta chiostra, fattogli a ciò da uno angel lo ’nvito. Quivi giacendo assai spiriti truova, che d’avarizia piangon l’acquisito in giù rivolti e, perch’el non sen mova alcun, legati tutti; e quivi parla con un papa dal Fiesco; appresso pruova l’onesta povertà, ed a lodarla Ugo Ciappetta induce, i cui nepoti nascer dimostra tutti atti a schifarla, pien d’avarizia e d’ogni virtù vòti; e come poscia contro alla nequizia, passato il dì, cantando, vi si noti. Quindi, per tutto, novella letizia, ed il monte tremare infino al basso dimostra, mosso da vera giustizia. Qui truova Stazio non a lento passo salire in su, al qual Virgilio chiede della cagion del triemito del sasso. la quale Stazio assegna; indi succede al priego suo ancora a nominarsi. Quindi, com’uom ch’appena quel che vede crede, dichiara Stazio avanti farsi ad onorar Virgilio, e gli fa chiaro lui, per contrario peccato agli scarsi, aver per molti secoli l’amaro monte provato. E già nel cerchio sesto, parlando insieme, uno albero trovâro donde una voce lor disse il modesto gusto di molti; e, più propinqui fatti, chiaro s’avvider ch’ogni ramo in questo albero è vòlto in giù, e d’alto tratti vider cader liquor di foglia in foglia, e sotto ad esso spirti macri e ratti vider venir più che per altra soglia dell’erto monte, e pure in sù la vista alli pomi tenean, che sì gl’invoglia. Così andando infra la turba trista, raffigurollo l’ombra di Forese: con lui favella; e della gente mista più riconobbe, e, tra gli altri, il lucchese Bonagiunta Orbiccian; poi una voce all’albero appressarsi lor difese. Un angel quinci al martiro che cuoce gl’invita, ed essi, per l’ora che tarda era, ciascun n’andava sù veloce, mostrando Stazio a lui, se ben si guarda, nostra generazione, e come l’ombra prenda sembianza di corpo bugiarda, e come sia da passione ingombra: e, sì andando, pervennero al foco, prima che ’l santo monte facesse ombra; lungo ’l qual trapassando per un poco d’un sentieruolo udîr voci nemiche al vizio di lussuria, ed in quel loco più anime conobbe, che ’mpudiche furon vivendo, e Guido Guinizelli gli mostra Arnaldo in sì aspre fatiche. Ma, poi che s’è dipartito da elli, a trapassar lo foco i cari duci confortan lui, ch’appena in mezzo a quelli il trapassò. Di quindi a l’alte luci salir gl’invita uno angel che cantava, pria s’ascondesser li raggi caduci. Vede nel sonno poi Lia che s’ornava di fior la testa, cantando parole nelle quali essa chi fosse mostrava. Quindi levato nel levar del sole, Virgilio di sé stesso il fa maestro, sul monte giunti, e può far ciò che vuole. Venuti adunque nel loco silvestro truova una selva, ed in quella si spazia su per lo lito di Letè sinestro. Vede una donna, che a lui di grazia parla e con verissime ragioni: del fiume il moto e dell’aura il sazia. Di quinci a vie più alte ammirazioni venuto, sette candelabri e molte genti precedere un carro, i timoni del qual traeva, con l’alie in sù vòlte, un grifon d’oro, quanto uccel vedeasi, l’altro di carne, alle cui rote accolte da ogni parte una danza moveasi di certe donne, e nel mezzo Beatrice del tratto carro splendida sedeasi. Da così alta vista e sì felice percosso, da Virgilio con Istazio esser lasciato lagrimando dice. Appresso questo non per lungo spazio, con agre riprension la donna il morde, senza aver luogo a ricoprir mendazio; per che le sue virtù quasi concorde li venner meno, e cadde, né sentisse pria ch’alle sue orecchi, ad altro sorde, pervenne:—Tiemmi;—onde, anzi ch’egli uscisse, da una donna tratto per lo fiume, l’acqua convenne che egli inghiottisse. Poi quattro donne, secondo il costume di loro, il ricevettero, e menârlo di Beatrice avanti al chiaro lume. Qual gli paresse il suo viso, pensarlo ciascun che ’ntende può; poi la virtute gli mancò qui a poter divisarlo. I casi avversi appresso, e la salute della Chiesa di Dio, sotto figmento delle future come delle sute cose, disegna; poi il cominciamento di Tigri e d’Eufrate vede in cima del monte, e con Matelda va contento, e con Istazio, ad Eunòe prima; donde bagnato, e rimenato a quelle donne beate, finisce la rima, «puro e disposto a salire alle stelle».
AL PARADISO
«La gloria di Colui che tutto move» in questa parte mostra l’autore a suo poder, qual ei la vide e dove. Ed invocato d’Apollo l’ardore, di sé incerto, retro a Beatrice pe’ raggi sen salì del suo splendore nel primo ciel, là, onde a ciascun dice, men sofficiente, che retro a sua barca più non si metta fra ’l regno felice. E mentre avanti cantando travarca, de’ segni della luna fa quistione alla sua guida, e quella se ne scarca. Poi c’ha udita la sua opinione, e, premettendo alcuna esperienza, chiaro nel fa con aperta ragione, Piccarda vede, e della sua essenza nel primo cielo «per manco di voto» con lei favella; e, della sua presenza partita, Beatrice a lui divoto qual violenza il voto manco faccia distingue ed apre; e simil gli fa noto perché gli paia i cieli aprir le braccia a diversi diversi, e come siéno però presenti alla divina faccia; quindi, con viso ancora più sereno, se sodisfare a’ voti permutando si possa o no, a lui dichiara appieno; e nel ciel di Mercurio ragionando veloci passan. Lì Giustiniano prima di sé sodisfà al dimando; appresso, quanto lo ’mperio romano sotto il segno dell’aquila facesse gli mostra in parte, e poi a mano a mano, parlando seco, volle ch’el sapesse Romeo in quella luce gloriarsi, che fe’ quattro reine di contesse. Induce poi Beatrice a dichiararsi, «come giusta vendetta giustamente fosse vengiata»; e quindi trasportarsi nel terzo ciel, veggendo più lucente la donna sua, s’avvide. Ivi con Carlo Martel favella, il quale apertamente gli solve ciò che ’l mosse a dimandarlo, come di dolce seme nasca amaro; quindi Cunizza viene a visitarlo, e del futuro alquanto gli fa chiaro sovra i lombardi, e con Folco favella, che gli mostra Raab. Indi montâro nella spera del sole, onde una bella danza di molti spiriti beati vede far festa, e nel girarsi snella; de’ quai gli furon molti nominati da Tommaso d’Aquin, che di Francesco molto gli parla poi e dei suoi frati. Poi scrive un cerchio sovraggiugner fresco a questo, e ’n quel parlar Bonaventura da Bagnoreo del calagoresco Domenico, nel qual fu tanta cura della fé nostra e dell’orto divino, quanta mai fosse in altra creatura. Poi rincomincia Tommaso d’Aquino com’egli intenda: «Non surse il secondo» di Salamone, e con chiaro latino gliele dimostra, ed un lume giocondo l’accerta lor, più lieti e più lucenti, come i lor corpi riavran del mondo. Quindi nel quinto ciel di lucolenti spiriti vede una mirabil croce, della quale un de’ suoi primi parenti gli fa carezze, e con soave voce gli si discuopre, e mostra quale stato Fiorenza avesse, quando nel feroce e labil mondo fu da pria creato; quindi le schiatte più di nome degne nomina tutte, da lui dimandato. Poi gli fa chiare le parole pregne di Farinata, e ’n purgatoro udite, a lui mostrando del futuro insegne. Appresso ancor con parole espedite gli nomina di quei santi fulgori Iosuè, Iuda, Carlo e più, scolpite da lui nel nominar per gli splendori cresciuti. E quindi nel Giove sen sale, dove un’aquila fanno i santi ardori di sé mirabile e bella, la quale gli solve il dubbio d’un che nato sia su lito, senza udire o bene o male di Dio, mostrando quel che di lui fia; quindi Davit e Traiano e Rifeo gli mostra, ed altri en la sua luce dia. Poi ’l chiarisce d’un dubbio che si feo in lui, de’ due che appaion pagani nel primo aspetto. Quindi uno scaleo, salito nel Saturno, di sovrani lumi ripien discerne, onde altro scende ed altro sale, e con Pier Damiani ragiona lì; e qual quivi risplende gli parla e noma più contemplativi quel Benedetto onde Casin dipende. Sal nell’ottavo del poscia di quivi, e, nel segno de’ Gemini venuto, le sette spere ed i corpi passivi si vede sotto i piè. Poi conosciuto Cefas, sua fede e suo creder confessa, da lui richesto, a lui tutto compiuto. Con voce appresso lucolenta e spressa al baron di Galizia la speranza dice che è, e che spetta per essa; indi venire a così alta danza Giovanni mostra, il qual del corpo morto di lui di terra il cava d’ogni erranza. Poi seguitando, al suo domando accorto, che cosa sia la carità, risponde, e qual da lei gli proceda conforto. Appresso scrive come alle gioconde luci s’aggiunse quel padre vetusto che prima fu da Dio creato, e donde tutti nascemmo, e per lo cui mal gusto tutti moiamo: il qual del suo uscire laonde posto fu, e quanto giusto in quello stesse, e quanto il gran desire di quella gloria avesse, e la dimora quanto fu lunga qui dopo ’l fallire gli conta, ed altre cose. Indi colora, quasi infiammato, il vicaro di Dio contr’a’ pastor che ci governano ora. Poi come nel ciel nono sen salío discrive, dove l’angelica festa in nove cerchi vede e ’l suo disio; di lor natura lì gli manifesta con sermon lungo assai mirabil cose, e della turba che ne cadde mesta. Poi vede le milizie gloriose del nuovo e dell’antico Testamento, che bene ovrando a Dio si fêro spose nel ciel più alto sovra il fermamento, dove ’l solio d’Enrico ancor vacante discerne. E quivi lui, che stava attento a riguardar le creature sante, lascia Beatrice, ed in loco di lei Bernardo con lo sguardo il guida avante, dove, poi c’ha orazione a lei, cui seder vede dove la sortiro gli merti suoi, gli è mostrata colei che sposa antica fu del primo viro, Rachel, Sara, Rebecca e ’l gran Giovanni, che pria il deserto, e poi provò il martíro. Appresso poi in più sublimi scanni Francesco ed Agostino e Benedetto, e quei che trapassar ne’ teneri anni, vede, de’ quali il dottor sopra detto, dico Bernardo, ragionando ad ello, caccia ogni dubbio fuor del suo concetto. Quindi il santo grazioso e bello più ch’altro di Maria gli mostra il viso, e davanti da lei quel Gabriello che ’l decreto recò di paradiso della nostra salute, tanto lieto che qui per non poter ben nol diviso: onesto l’uno e l’altro e mansueto. Adamo e Pietro e poi il vangelista Giovanni lì seder vede, ripleto d’alta letizia, e quindi il gran legista Moisé vede, e poi Lucia ed Anna; e punto fa alla gioiosa vista. Appresso, acciò che la divina manna discenda in lui, e faccial poderoso a veder ciò per che ciascun s’affanna, umile quanto può, nel grazioso cospetto della Madre d’ogni grazia, insieme col dottor di lei focoso orando, priega che la vista sazia del primo Amor gli sia, e per lo lume, che senza fine profondo si spazia, ficca degli occhi suoi il forte acume; poi, disegnando quanto ne raccolse, termine pone al suo alto volume, mostrando come in quel tutto si volse l’alto disio ed alle cose belle, e come ogni altro appetito gli tolse «l’Amor che muove il sole e l’altre stelle».

